|
|
|
|
| |
| Quando si suona una scala dalla radice
all'ottava, l'orecchio organizza il suono della scala in dipendenza della nota
di inizio e |
| della risoluzione delle note
all'ottava. La stessa cosa avviene quando si discende dall'ottava alla radice. |
| Se si cambia l'altezza della
nota di inizio (ad esempio da C a D) e si mantiene intatta la struttura degli
intervalli, l'orecchio |
| percepisce che si sta suonando la stessa
scala ma ad un'altezza maggiore. Conseguentemente, dal momento che non si è |
| alterata la struttura degli intervalli,
si può traslare la scala verso l'alto o verso il basso e la qualità del suono
della scala rimane |
| facilmente riconoscibile. Ma se si cambia
la struttura di intervalli, la scala risultante avrà una qualità di suono
differente. Qui è |
| dove entra in gioco il modo. |
| Il modo consente di generare una
struttura di intervalli che è differente dalla Scala Maggiore e
conseguentemente produrre |
|
un'unica qualità di suono. |
|
| I modi vengono generati
prendendo una scala con inizio e fine su una nota, all'interno della scala, differente
dalla nota di |
| radice (root). |
| Per esempio, se consideriamo la Scala
Maggiore di C (C D E F G A B C), iniziando e finendo sulla nota D, invece di C, |
| otteniamo: D E F G A B C D |
| stiamo ancora suonando le
note della Scala Maggiore di C, ma iniziando e finendo sulla nota D si rende il suono
come se la |
| nota di radice fosse D. Occorre
suonare la scala diverse volte in questo modo per percepire D come centro
tonale. |
| E' imperativo a questo punto non suonare
note differenti, oppure l'effetto svanirà. |
| Ora che il centro tonale si è stabilito
come D, arriviamo al nuovo suono della scala. |
| La scala non suona più come C Maggiore
perchè il nostro orecchio percepisce la risoluzione su D. |
| Se confrontiamo questa nuova scala con la
scala di D Maggiore scopriamo che essa è differente. |
| Le note della Scala Maggiore di D sono:
D E F# G A B C# D |
| La nostra nuova scala contiene F naturale
e C naturale, che sono due suoni molto importanti nella scala. Alterando il 3° e
7° |
| grado della scala il suono cambia
drammaticamente. |
|
Questa nuova scala viene chiamata Scala Dorica. La nota di radice è D; Dorica è
la classificazione per questo nuovo suono ed |
| il modo indica che l'inizio e
la fine è su una nota diversa dalla radice della scala che l'ha generata. |
| La cosa importante da capire
a questo punto è che la nuova scala è una scala di "D". Spesso si assume che
tale scala sia una |
| sostituzione della scala di C
Maggiore. Invece di pensare questa nuova scala come dipendente da C occorre
pensare ad essa |
| solo come dipendente da
D; questo farà capire più velocemente
la teoria che sta dietro ai modi. |
|
| Ora, se confrontiamo il modo D
Dorico con la Scala Maggiore di D scopriamo che la scala dorica ha la seguente
struttura di |
| intervalli: 1 2 b3 4 5
6 b7 8 |
| La struttura degli intervalli
di una scala è molto importante; questo è ciò che definisce il suono
caratteristico della scala. |
| La struttura degli intervalli
indica inoltre come e quando può essere utilizzata una scala. |
|
| Si tenga presente che i sette
modi di seguito elencati condividono lo stesso segno di chiave; ossia sono tutti
composti |
| esattamente con le stesse
note. L'unica cosa che li distingue è il fatto che essi utilizzano una
differente nota come radice. |
| Ora, se si cambia la chiave
della scala maggiore (Parent Major Scale), otteniamo gli stessi modi, nello
stesso ordine, ma le |
| note di radice cambieranno. |
| Per esempio, consideriamo la
chiave di G Maggiore: |
|
|
MODO |
NOTA |
SCALA |
| 1 |
G |
IONIA |
Ionian |
| 2 |
A |
DORICA |
Dorian |
| 3 |
B |
FRIGIA |
Phrygian |
| 4 |
C |
LIDIA |
Lydian |
| 5 |
D |
MISOLIDIA |
Mixolydian |
| 6 |
E |
EOLIA |
Aeolian |
| 7 |
F# |
LOCRIA |
Locrian |
|
|
| Questo evidenzia, se non già
notato, che il Modo Ionio e la Parent Major Scale sono la stessa cosa. |
| Può essere utile pensare "modo
di suonare una scala" in sostituzione della parola "modo"; così la
vecchia Scala Maggiore, |
| come la si è sempre
conosciuta, è il 1° modo o Modo Ionio. |
| Un esempio, rozzo ma pratico,
che rende più comprensibile l'utilizzo dei modi può essere il seguente: il modo
DORICO suona |
| come se il gruppo stesse
suonando in "D" ma invece tu stai suonando la melodia in "C". |
|
|
Per ulteriori dettagli si veda la pagina specifica di trattazione
SCALE |
|
|
|
ESEMPIO PRATICO in prestito dal BLUES |
|
|
|
Consideriamo il seguente esempio pratico (preso in prestito dal Blues) che
meglio chiarisce il significato di modo. |
|
Nell'esempio riportato la tonalità di base (espressa in chiave) e la
progressione degli accordi differiscono; ovvero il centro tonale |
|
della progressione differisce dalla
tonalità espressa in chiave; o meglio ancora, la progressione ha il centro
tonale su un |
|
determinato
modo della tonalità espressa in chiave. |
|
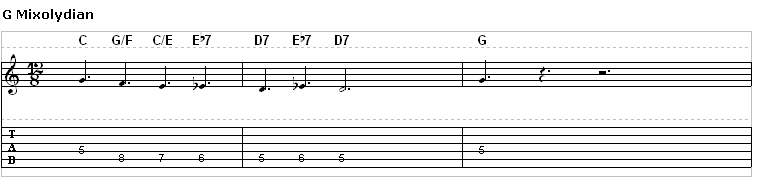 |
|
In chiave non abbiamo alterazioni, siamo quindi in chiave
di "C", e la progressione degli accordi ha il
centro tonale in "G". |
|
L'intervallo dal "C" al "G" è una
QUINTA ed il modo
che si sviluppa sul V° grado della Scala Diatonica
Maggiore è il MISOLIDIO; |
|
avremo quindi una scala di G Misolidio. |
